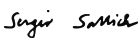Da Beethoven, Wagner prese il concetto dell’arte come serie successiva di crisi e di risoluzioni, di annientamento e di riedificazione, di impegno morale, portato ad un grado massimo di sacrificio e di ebbrezza. Si potrebbe aggiungere che, per quanto almeno riguarda il mondo dei suoni, l’idea rivoluzionaria fu idea di origine perennemente tedesca (fuori dell’arte dei suoni, funestamente tedesca). Rivoluzioni vere e proprie, anche se proporzionate alle armi disponibili nella loro epoca, furono quelle di Gluck, di Weber, di Beethoven, e di Wagner: tali non soltanto per i contenuti e le conseguenze, ma anche per volontà consapevole, per scelta consapevole di esserlo.
Anche lui, Wagner, si appoggiò a qualche cosa. Ma i suoi punti di appoggio furono tutti remoti, aleatori e invisibili, come sono remoti, aleatori e invisibili, l’idea della tragedia greca da riproporre come modello imperituro, il concetto di un dramma totale onnicomprensivo, il senso di un eroismo artistico da perseguire ad ogni costo, la superbia di dare una risposta a definizioni universali, la battaglia con la vita, specchio e misura dell’arte, l’altra e più vera faccia dell’esistenza.
Cresciuto in una famiglia di attori e di teatranti, Wagner fu un fanatico del teatro, un «teatromane»: un genio teatrale. In un arco di tempo relativamente breve se rapportato alle consuetudini e alle tradizioni consolidate dell’opera in musica, egli rivendicò – e riuscì a imporla a un pubblico eterogeneo, spaccandolo a metà ma comunque coinvolgendolo – la pretesa rivoluzionaria che un evento teatrale potesse essere un’opera d’arte nel senso assoluto della parola. Il concetto wagneriano di «opera d’arte totale», sinonimo ampolloso e superbo di «teatro», e quello ad esso strettamente connesso di Festival, non si esauriscono infatti nell’ovvia constatazione che varie arti si fondono e collaborano serbando ognuna i propri diritti, né in quella, già di per sé più problematica, che nello stesso tempo esse si completano e si superano nella totalità inseparabile di parola, azione e musica; quei concetti richiedono in primo luogo che in «teatro» come «opera d’arte totale» rappresenti la quintessenza dell’arte, sia cioè un evento metafisico potenziato dal concorso di tutti i mezzi d’espressione ed elevato alla stessa dignità della creazione musicale assoluta, della Sinfonia e delle altre forme strumentali classico-romantiche.
Questa pretesa estetica, che portò a un sovvertimento radicale dei valori – cosa di cui Wagner fu senza dubbio consapevole – si legava a un’esigenza culturale e sociale altrettanto drastica: il teatro musicale, un genere che era stato per metà spettacolo di rappresentanza e per metà svago, doveva costituire al contrario una forma ideale di conoscenza, un’esperienza unica e irripetibile, alla quale accostarsi con religiosa concentrazione, come a un rito.
L’idea di Festival che Wagner impose al suo fedele pubblico di Bayreuth – un pubblico costretto, prima suo malgrado, poi per scelta, ad elevarsi al rango del creatore – non ha altro significato che questo. Per Wagner il teatro non si esauriva più nell’«opera», riprodotta in modo sempre mutevole, ma sì trasformava in avvenimento creativo virtualmente infinito; alla forma apparente nella quale si incarnava lo spettacolo d’opera con tutte le sue molteplici variabili e varianti, Wagner costituì il concetto di essenza immutabile, da contemplare e da riflettere.
Ben oltre le vicende della sua vita, il teatro di Wagner è una rivoluzione permanente, tanto più acuta là dove apparentemente abdica e ripiega su se stessa. Rivoluzionaria è la concezione teatrale, che agisce, improvvisamente e simultaneamente, su zone diversissime della conoscenza, dell’attività immaginativa e della memoria. Rivoluzionaria è la forma poetica, pensata e scritta in attesa della musica, fonte d’intuizione più che di giudizio o di descrizione: gli squarci verbali di Wagner e la sua sintassi a volte anarchica sono preludi a un modo posteriore di fare poesia. Rivoluzionaria la musica, soprattutto, intreccio inestricabile di melodia, di ritmo, di timbro, di armonia spinta a temerari scoprimenti, di costruzioni sonore e di architetture in suoni dalle molteplici, incommensurabili relazioni.
La conquista dell’inconscio, operata da Wagner ed operata per la sola strada possibile, quella della musica, illuminò orizzonti imprevisti e ai suoi tempi imprevedibili. Anche l’idea wagneriana di togliere, a soggetto dei suoi drammi, racconti leggendari, miti antichi e antiche favole, non fu soltanto rifiuto del realismo e del principio borghese della verosimiglianza; fu anche sensazione che quelle creature irreali, nate dalla fantasia di poeti anonimi e dì epoche oscure, permettessero di per se stessi un giuoco più ricco di estensioni psicologiche, di richiami, di propagazioni, di scambi incessanti fra la loro apparenza attuale e la loro consistenza mitica, sovrastorica, universale. «Non appena gli avvenimenti si sono svolti davanti ai nostri occhi» – scrisse un giorno Wagner – «essi diventano meno importanti di quanto si svolge entro l’anima dei personaggi che ne sono i protagonisti». E in quel momento i protagonisti diveniamo noi, introdotti e stregati in uno stato di veglia e di sonno. Ricordiamo Giulio Confalonieri: “”Wagner ha dissolto nella libera cadenza del sogno il limitato contorno degli avvenimenti concreti; ha sommerso il pensiero e le sue compiacenze in un oceano di generosità primitive; ha espresso tutto ciò che urgeva, da oltre un secolo, sulle soglie dell’anima umana che lo spirito dell’Ottocento aveva reso ormai indifferibile».
Nuova Civiltà, aprile 1984