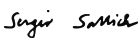Festival, festival, fortissimamente festival. Quante sono oggi in Italia le manifestazioni musicali che, quale più quale meno, si richiamano all’idea di festival? Impossibile contarle. Da quelli «grandi», per età se non per sempre costante qualità, a quelli nati da poco, di salute precaria e dal futuro ancor più dubbio, il numero dei festival è cresciuto a dismisura, nei luoghi più diversi e nelle stagioni più favorevoli, accavallandosi in una matassa inestricabile. Lo sa bene chi per mestiere è subissato da comunicati-stampa che invariabilmente magnificano le bontà dell’iniziativa (altro tratto dell’idea «moderna» di festival), esaltandone le virtù e celebrandone in anticipo i trionfi. Che poi, magari, non verranno.
In via di principio, non ci sarebbe nulla da eccepire contro la proliferazione dei festival, se ciò fosse un sintomo concreto di crescita culturale e musicale. Non è sempre così. Questo aumento sfrenato e confuso di iniziative musicali è anzi la dimostrazione del caos che regna nel nostro Paese, dove l’istruzione musicale è allo sbando, i teatri e le istituzioni concertistiche versano in una crisi grave, i luoghi di ascolto della musica sono quanto mai precari e inefficienti; eppure, a nessuno viene negata la possibilità di industriarsi per creare un nuovo festival, con motivazioni e fini sovente estranei a reali bisogni artistici. Premessa indispensabile sembra essere l’attrattiva del posto, il binomio villeggiatura-musica; anche se poi l’ascolto sarà del tutto inadeguato e la sostanza della proposta debole, poco o nulla radicata nella storia locale. E con il contributo di chi avviene tutto ciò? Il ritorno di immagine, vero o presunto che sia una volta che si superi l’impaginazione imbonitoria della presentazione, può allettare qualche sponsor; ma sono soprattutto le mille vie tortuose delle piccole o grandi sovvenzioni comunali, provinciali o regionali, e anche ministeriali se si dispone dell’appoggio giusto, a fornire la base economica per il banchetto festivaliero. Al termine del quale non tutti saranno soddisfatti, e neppure rimborsati. Ma poco importa. Passata la festa, se ne comincia un’altra, in questo Paese che non riesce a dimostrarsi adulto, non si dice per la vita dell’arte, ma neppure per la democrazia delle autonomie locali.
Un tempo esistevano solo due festival, il Maggio Musicale Fiorentino e il Festival di musica contemporanea a Venezia, ma erano manifestazioni importanti, trainanti su scala internazionale. Oggi la Biennale di Venezia è in agonia, e il Maggio ha perduto la sua identità: ciò che una volta era concentrato in queste sedi, si trova sparpagliato dovunque, senza che sia più possibile tirare le fila. Questa dispersione è tipica delle età di tramonto, nelle quali un’eccitazione frenetica per l’attivismo si sostituisce alla tranquilla, operosa meditazione creativa. E neppure la moltiplicazione delle proposte è garanzia di qualità.
Un festival non è semplicemente una serie di manifestazioni che accosti interpreti di grido (quando ci sono) o musiche tagliate per essi, fra loro indifferenziate: dovrebbe essere un’occasione per riflettere su un tema, o fare il punto su una situazione. Ciò può avvenire su un autore, su un periodo, su un determinato momento della nostra storia, del nostro passato o del nostro presente. Del nostro presente, soprattutto: dato che del passato è difficile dare un’immagine nuova quando tutti i motivi sono stati esauriti. Che cosa può dire oggi di nuovo Bayreuth per Wagner, che non sia già stato detto o che non venga detto anche altrove? Abbado che dirige Lohengrin a Vienna, o Muti che affronta per la prima volta Parsilal alla Scala, sono fatti anche più speciali nella storia attuale dell’interpretazione wagneriana della routine di Bayreuth; il cui specifico viene automaticamente depotenziato nel momento in cui Sinopoli rifà le stesse cose a Taormina. È ridicolo pensare a un festival Puccini a Torre del Lago, dove l’ascolto è puramente immaginario, o a un festival Verdi a Parma: a meno che non si forniscano per l’occasione le premesse per esecuzioni esemplari, in edizioni ineccepibili e capaci di costituire un modello interpretativo per tutti. Altrimenti, Puccini e Verdi non hanno bisogno di festival. E qui sta la differenza con Pesaro, l’unico festival monografico italiano di importanza storica: per il semplice fatto che a Pesaro si è fatto Rossini, almeno nella scelta dei testi e degli interpreti vocali, in un modo diverso, speciale, legandolo anche al ripristino di edizioni critiche filologicamente corrette, a cura della Fondazione Rossini.
L’aspetto paradossale di tutto ciò sta nel fatto che l’idea stessa di festival come manifestazione propositiva tendenzialmente unica nel suo genere è ormai usurata, proprio nel momento in cui invece si moltiplica rispecchiandosi illusoriamente in parerga e paralipomeni: della cui utilità non sempre si può essere sicuri. Naturalmente ci sono le eccezioni. Il torinese Settembre Musica, per esempio, aggancia attorno a un tema della musica contemporanea, a un autore vivente e presente alle esecuzioni, tutta una serie di svolgimenti e pensieri ben individuati, che non saranno forse nuovi (ma dov’è il nuovo oggi?), ma che hanno comunque un senso: un po’ come su grande scala e con altri mezzi sta facendo «Wien Modern» (non è infatti che dall’estero ci vengano molti altri esempi significativi: con la differenza che all’estero i festival tendono a ridursi, non a proliferare). Anche Ravenna ha imboccato una strada interessante, che un tempo era onorata dal Maggio Fiorentino: non foss’altro per la riproposta di autori e opere di non frequente esecuzione, e non precisamente balneari, come Cherubini e Auber. E anche Napoli – e le sue Settimane Musicali Internazionali – sta cercando una più precisa connotazione con il recupero degli autori del barocco napoletano, se non proprio sconosciuti, quasi. La presenza di grandi artisti è naturalmente decisiva per il successo di un festival: ma se non è mirata a uno scopo, finisce per essere un fuoco fatuo.
Nel termine di festival è insito un principio di festa, di gioco, di novità. I1 festival dovrebbe darci l’inusitato, ciò che normalmente non si trova nelle stagioni normali, nella vita, anche musicale, di tutti i giorni. Più che rassicurarci, o annoiarci, su ciò che già sappiamo, dovrebbe stimolarci a nuove scoperte, a nuove emozioni. È bello sapere che un giorno, magari anche in un luogo particolarmente affascinante, impareremo qualcosa di nuovo, rifletteremo su qualcosa che fino a quel momento era rimasto nelle pieghe della nostra coscienza. Questo dovrebbe dare un festival. Non il testo puramente pretestuoso, la regia eccentrica, il divo in costume da bagno, l’orchestra in spedizione turistica, l’opera o il concerto in versione mare o montagna. Arrivo a dire che il festival dovrebbe essere una cosa rara, a cui accostarsi con lunga attesa, trepidazione e gioia, un bene prezioso da non dilapidare nella frammentazione delle vanità. Ma questa è pura utopia in un Paese dove la norma è eccezione, e l’eccezione dimostrazione di furbizia.
Do Maggiore, Settembre 1991