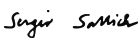Sotto l’etichetta “”Giornate del teatro musicale contemporaneo”” l’Opera di Stato di Monaco ha sciorinato in quindici giorni scarsi tutto il suo repertorio di opere del Novecento, offrendo un’occasione unica per ripercorrere alcune delle tappe fondamentali della storia della musica del nostro secolo. Alcuni di questi allestimenti appartengono a quanto di più interessante si possa vedere oggi dal punto di vista scenico in teatro: in particolare Lulu e Cardillac di Ponnelle, Wozzeck di Dieter Dorn, lo stesso Peer Gynt di Kurt Horres, mal servito però dalla musica francamente riprovevole di Werner Egk. Sotto l’aspetto musicale si tratta di esecuzioni per lo più corrette e civili (salvo Cardillac resa splendente da Sawallisch), non certo in grado di entusiasmare ma capaci di dare in modo adeguato il senso delle partiture. Noi non ci accontenteremmo; in Germania, sì.
In apertura del breve festival, è stata rappresentata in prima mondiale la nuova opera Belshazar del quarantaquattrenne compositore di Magonza (che è poi la città in cui ha sede la casa editrice Schott, beato lui) Volker David Kirchner, nome che in Germania gode di una buona reputazione e, come si diceva, di ancor migliore rappresentanza. Assistendo a questo lavoro, abbiamo capito quali siano gli ingredienti necessari per cucinare un’opera “”attuale”” e per entrare di diritto nell’accademia della musica contemporanea.
Soggetto: biblico, allegorico (ahi Babilonia, la babele dei linguaggi), fortemente contrastato; ma che sia chiaro quali sono i buoni e quali i cattivi. Ciò rende possibile fra l’altro di vestire i cattivi da nazisti o colonnelli o comunque dittatori, i buoni da straccioni del sottoproletariato (ma questo è strano, perché non è che il sottoproletariato sia molto amato in Germania): la regia è così assicurata (Kurt Horres). È gradito che alla fine i buoni muoiano, ma naturalmente non prima di aver moralmente vinto; il cattivo (Belshazar, appunto) è roso dal dubbio, si contorce e alla fine forse si pente (questo andrebbe benissimo anche in Italia). Ottimo, per chiudere, il mormorio sommesso del coro invisibile dietro la scena.
Musica: se babele deve essere, che babele sia fino in fondo. Strumentazione massiccia, con molte percussioni: e che suonino molto forte, per fare impressione e dare l’idea che si stanno dibattendo temi importanti. Il Profeta, quello buono, lanci i suoi ammonimenti con urla acutissime, su note fisse e ribattute; i salti ampi, le dissonanze, i ripiegamenti cromatici (con privilegio accordato alla seconda minore discendente) siano riservati invece al conturbato peccatore, in lunghi monologhi. Benissimo gli interludi orchestrali; qua e là un tocco di dodecafonia, tanto poi nessuno se n’accorge. E infine la ciliegina sulla torta: quando si avvicina la trasfigurazione, musica tonale; armonie diatoniche, cantilene soavi (strumentazione: flauto solo), salti di quinta e di quarta, melodie sempre più spoglie (ecco la purezza, si passa all’oboe solo), magari un pizzico di quinte vuote. Luci in dissolvenza, la scena che cade per far vedere la “”struttura”” nuda del teatro (è chiaro che Babilonia siamo noi), Dio vince, l’uomo anche, svanire in pianissimo. Sipario e applausi.
Se poi l’opera la chiamate Musikdrama, come fa Kirchner, rivelando anche scarsa conoscenza della storia del teatro musicale (ma questo non importa), e accentuate la “”problematica”” morale, religiosa o semplicemente “”umana”” (l’uomo è solo nella disgregazione dei linguaggi, non comunica, cerca Dio: lo troverà?), avete buone possibilità di sembrare “”attuale”” e di far presa sul pubblico; anche sui giovani, che a Monaco erano tanti e applaudivano convinti. Sempre che sappiate procurarvi anche un buon editore.
Ma perché quando queste cose le ascoltiamo in Moses und Aron, in Lulu o in Pelléas et Mélisande ci sembrano così vere e commoventi, mentre nell’opera di oggi ci suonano così false e vuote? In fondo, il peggior regalo che potevano fare a Kirchner era proprio quello di metterlo accanto a questo repertorio, a rappresentare la notte fonda fra le ancor belle giornate autunnali del teatro musicale contemporaneo.
Musica Viva, n. 3 – anno X