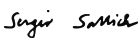Sfidarsi per capire
C’era molta attesa, anzi eccitazione per quella che veniva definita la prima volta di Muti e Pollini insieme (anche in televisione, Albertazzi in veste di presentatore per Rete Quattro lo ripeteva con una certa soddisfazione). Non era vero che fosse la prima volta in assoluto (questo stesso pezzo, il Primo Concerto di Brahms, lo avevano per esempio già suonato insieme poche settimane fa a Filadelfia), ma era la prima volta alla Scala, e tanto bastava ad accrescere la curiosità, e a suscitare memorie quasi storiche di altri sodalizi, di altre scelte, anche di campo. Noi tutti, ascoltatori e critici, siamo spesso involontariamente portati a ragionare per schemi, anche se poi non corrispondono alla realtà; e la pretesa di una lontananza di Muti da Pollini, e di Pollini da Muti, quasi stratificata nel tempo, sembrava appunto uno di questi.
L’incontro è invece avvenuto puntualmente e ha dato frutti cospicui. Si è trattato però di qualcosa di speciale, che dovremmo considerare su due piani diversi, quello esecutivo e quello interpretativo. Non sono chiaramente due piani distinti, ma diverso era l’atteggiamento dei due musicisti in ognuno di essi. L’aspetto esecutivo, anzitutto: Muti ha accompagnato Pollini con molta scioltezza e attenzione, con cura estrema dei particolari e intesa rivolta alla precisione dell’insieme, alla cucitura del discorso orchestrale con quello pianistico. Dal punto di vista tecnico non ci sono state sbavature né da una parte né dall’altra, tutto risultava perfettamente integrato e risolto. E già questo faceva un gran bell’effetto, era per così dire una dimostrazione di bravura e di serietà. Ma che cosa accadeva invece sotto il profilo interpretativo? Accadeva che fin dall’introduzione orchestrale del primo movimento Muti proponesse una sua visione di Brahms, soprattutto del suono e del fraseggio, e Pollini gli rispondesse con le sue idee lucidamente enunciate e motivate, che non erano le stesse idee di Muti e talvolta anzi se ne discostavano sensibilmente. Strada facendo, ciascuno sviluppava questo percorso portandolo fino all’estremo della coerenza e dell’evidenza, forzandone anzi alcune conseguenze: e sempre piú ci si accorgeva che i due percorsi, partiti da premesse diverse, convergevano verso uno stesso punto nel quale le ragioni dell’uno e dell’altro diventavano le ragioni di Brahms, in quest’opera di svolta e di accumulo di materiale contrastante, rese in modo tumultuoso e nello stesso tempo logico.
Di solito, quando due artisti anche grandi collaborano senza che si siano stabilite in precedenza certe affinità elettive si raggiunge un compromesso, incontrandosi a mezza strada. Non qui. Muti e Pollini si confrontavano a testa alta, quasi sfidandosi a vicenda in una gara che non ammetteva cedimenti di nessun tipo. Ma c’era una cosa che li accomunava: la profondità e la qualità della loro ricerca su Brahms, e su tutta la musica che vi era coinvolta, con la voglia di andare fino in fondo per provare a capire e a realizzare individualmente tutto ciò che vi è contenuto. Ed è lì che avveniva il contatto, con la forza di un imperativo assoluto.
Dopo il Primo Concerto di Brahms, Muti ha diretto come da nessuno abbiamo mai sentito fare alcuni brani della Suite dalla Turandot di Busoni e ha rispolverato Il poema dell’estasi di Skriabin, già proposto nella recente tournée con l’Orchestra di Filadelfia. Pezzi che la Filarmonica della Scala è oggi in grado di affrontare con sicurezza e autorità, doti specifiche che rivelano un singolare orgoglio in un’orchestra molto cresciuta, ma che sbaglierebbe tuttavia a credersi già arrivata.
Musica Viva, n.8/9 – anno XV