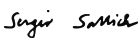Webern
Le opere complete (opp. 1-31)
Juilliard String Quartet; Heather Harper, Halina Lukomska, soprani; Isaac Stern, violino; Gregor Piatigorsky, violoncello; John Williams, chitarra; Colin Bradley, clarinetto; Charles Rosen pianoforte; John Alldis Choir; London Symphony Orchestra, direttore Pierre Boulez (registrazioni: Londra e New York, 1967-71)
Sony SM3K 45845 ADD (3 Cd)
Questo riversamento in Cd “”ad alta definizione di suono”” di vecchie registrazioni Cbs già apparse in cofanetto nel 1978 è importante per almeno due motivi. In primo luogo perché ripropone con tecnica assai migliorata (e in questo caso il vantaggio è incalcolabile, per musiche che sovente aspirano a raggiungere la soglia indistinta del silenzio, o viceversa la forza assoluta dell’esplosione tellurica) esecuzioni di sconfinata bellezza, vere e proprie pietre miliari nell’interpretazione della musica del nostro secolo. In secondo luogo – e ciò non sembri in contraddizione – perché offre la testimonianza di un modo di intendere e di volere la musica di Webern che oggi, vent’anni dopo, appare “”superato”” in primo luogo dallo stessc protagonista indiscusso di tutta l’impresa, ossia Pierre Boulez: interprete storico, ma anche per così dire storicizzabile alla luce di un’evoluzione che con lui giunge fino ai nostri giorni.
La visione di Boulez (e potremmo annettergli anche quella del Quartetto Juilliard, che va nello stesso senso), quale si ricava da queste incisioni, è anzitutto il risultato di un atto di fede, sostenuto da una logica d’acciaio, nella musica di Webern considerata nella sua importanza linguistica e formale prima ancora che poetica: in altri termini, Boulez sottolinea programmaticamente e rende percepibile ciò che distingue Webern da tutti gli altri compositori della sua epoca sotto il profilo dello stile, sintesi essenziale di linguaggi e di forme, mettendo un chiaro, intenzionalissimo accento sulle tensioni verso un’idea di musica in sé perfettamente definita, ma aperta a ulteriori sviluppi. Sviluppo che Boulez sembra indicare drasticamente a se stesso prima ancora che agli altri.
Alla fine degli anni Sessanta, quando realizzava queste incisioni, Boulez, e non solo lui, poteva credere che Webern fosse il grimaldello che avrebbe dischiuso, con la forza del suo esempio, i tesori ancora nascosti della “”nuova musica””. E la inflessibilità, la durezza e la implacabile chiarezza con cui ne affrontava le opere dovevano costituire il paradigma di una svolta. In quel momento, questo significava l’impatto con Webern: il riconoscimento di un’annunciazionre, un vangelo da divulgare a chi sapesse comprenderlo e farsi discepolo, una religione dell’arte. Forse un modello di vita.
Da allora Boulez ha continuato a dirigere Webern, ma ha a poco a poco mutato prospettiva. Non sull’essenziale, come è chiaro, ma sulla reale portata di quel messaggio, e sulla sua intrinseca natura: Webern è l’ultimo anello di una catena che si perde nel vuoto. Da quel momento, che combacia col nostro presente, Webern è diventato per lui non un autore dimostrativo, ma un segno (o un sogno?) che porta alla poesia. E ciò che Boulez vi ha conquistato, e che paradossalmente altri prima di lui, così diversi da lui, come Sterno Piatigorsky, avevano immediatamente intravisto senz’ombra di ideologia (basta riascoltarli oggi, anche qui), è morbidezza, abbandono, illusione, fantasia, dolcezza, perfino canto. Quanti altri dischi sanno darci come questi il senso della storia che cristallizza, e del tempo che passa e tutto trasforma?
Musica Viva, n.8/9 – anno XV