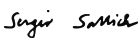Intanto, lo stesso giorno a Roma, sfilava in gran pompa la Tonalità. Noi alla prima del Salvatore Giuliano all’Opera di Roma non c’eravamo, ad applaudire il Nuovo Salvatore del melodramma Lorenzo Ferrero e a cantare in coro con lui “”Inneggiamo, la Tonalità non è mo-or-ta””, appena freschi del ripasso di Cavalleria rusticana, che gli era abbinata. Eravamo per l’appunto a Monaco. Ma ci andammo poi. Ed è chiaro che i due discorsi sono in qualche modo collegati.
L’operazione di Ferrero è assai più sottile di quella di Kirchner, ma persegue lo stesso fine: cercare l’attualità dell’opera e trovare i mezzi per comunicarla. Se Kirchner opta per l’eterogeneità linguistica e per una tematica a sfondo morale e religioso, Ferrero sceglie verità storica e soggetto politico-sociale su un linguaggio di stampo neoverista e chiaramente melodrammatico. Non soltanto recupera la tonalità per rendere unitario il percorso drammatico-musicale, ma si affida anche a un declamato intensamente melodico, per quanto fatto di giri di frase brevi e chiusi, a una ritmica incisivamente descrittiva, a impasti timbrici che mirano a connotare la qualità di una situazione o di uno stato d’animo. Sul libretto di Giuseppe Di Leva, la musica di Ferrero agisce per così dire dall’esterno: ora si sforza di interpretare il testo cogliendone gli spunti dominanti, ora lo commenta e lo illustra con piana scorrevolezza sinfonica, in attesa di un nuovo punto culminante, di un altro sfogo vocale.
Ferrero non è però un epigono del melodramma, come lo può essere, pur nel senso migliore della parola, Menotti, bensì un compositore di oggi, per di più giovane, che sa molto bene quanti e quali riferimenti comporti la scelta di un linguaggio di questo genere. Operazioni simili possono avere un significato o in polemica con le condizioni attuali della musica contemporanea, rifiutandone i valori dominanti, o come parodia stilistica, ritorno a un genere di cui si voglia riaffermare il valore e l’attualità. Ferrero col Salvatore Giuliano evidentemente si rifiuta di impegnarsi nei problemi, anche drammaturgici e poetici, del teatro musicale contemporaneo, ma non ha e non può avere l’immediatezza per presentare in termini di attualità una stagione del melodramma colta già del suo crepuscolo. In questo senso, rifare Mascagni o Puccini è assai più difficile che riallacciarsi a Mozart o a Rossini. Viene dunque il sospetto che l’operazione di Ferrero abbia altri fini, prima di tutto quello di aggirare l’ostacolo che separa la musica d’arte dal grande pubblico. Chi come noi ha assistito a Monaco alla sua show-opera Night può testimoniare che Ferrero ne ha le possibilità, solo che sappia scegliere quale è il suo pubblico. E la sua dimensione di compositore. Altrimenti rischierà di farci riscoprire soltanto quanto sia geniale e spettacolare Cavalleria rusticana (lasciando stare Puccini, lui proprio sta in un altro mondo) e di indurci a credere che la storia di Salvatore Giuliano sia stata appena un cattivo western all’italiana la cui colonna sonora, sceneggiata e cantata, approdò un giorno in teatro. Con il bandito che cercava, chissà poi perché, di rifare Turiddu.
Musica Viva, n. 3 – anno X